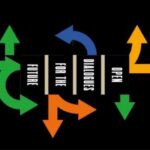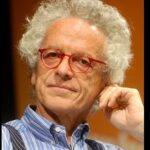Una regione, il Friuli Venezia Giulia, che in un triennio sicuramente complesso e sfidante, è riuscita a crescere, a esportare – più del resto d’Italia – ribadendo la sua posizione strategica privilegiata al centro d’Europa. Udine punta a diventare anche il centro del dibattito e della riflessione sui grandi temi geoeconomici e geopolitici, con il nuovo forum “Open Dialogues for Future”, ideato ed organizzato dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine, con la collaborazione di The European House – Ambrosetti e la direzione scientifica del giornalista e saggista Federico Rampini, il quale, assieme al presidente Giovanni Da Pozzo, ha aperto i lavori in una Sala Valduga sold out – così come le altre sale della sede camerale di Udine, collegate in videoconferenza. In avvio dei lavori è stato anche trasmesso il videomessaggio del Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

«La nostra Cciaa – ha detto Da Pozzo – ha iniziato a parlare di futuro nel 2010, quando non era così abituale. Con questo nuovo forum continuiamo a farlo, con un taglio che valorizza maggiormente il ruolo di Udine e del Friuli, un ruolo di traino dimostrato anche con uno sviluppo economico e con un export cresciuto di oltre il 51,3% tra terzo trimestre 2021 e 2022 e che punta ad affermare questa sua posizione privilegiata anche nell’ambito della riflessione sugli scenari futuri».
«Da Pozzo ha ricordato una cosa interessante – ha aggiunto Rampini – l’exploit delle esportazioni. Ricordiamoci dove eravamo un anno fa, poco dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: circolavano visioni allarmistiche sull’effetto guerra e sanzioni. I profeti dell’apocalisse predicevano un inverno al gelo e penurie alimentari. Nulla di tutto questo è accaduto. Lo scopo di questo forum è proprio darci, tutti, degli strumenti di interpretazione del mondo più affidabili rispetto a queste facili profezie di sventura».
Il presidente di Unioncamere Andrea Prete, l’assessore alle attività produttive Sergio Bini e il sindaco di Udine Pietro Fontanini hanno portato i loro saluti in apertura, in rappresentanza degli enti che hanno dato il patrocinio all’evento, sostenuto anche da Fondazione Friuli.
Nel suo intervento, l’assessore Bini ha sottolineato la profonda necessità di approfondire le tematiche della politica internazionale in ottica presente e soprattutto futura e di includere coloro i quali ne saranno protagonisti, ovvero i giovani, coinvolti direttamente in un’epoca di rapidissimi cambiamenti.
Per il presidente di Unioncamere Prete, «Open Dialogues significa interpretare alla grande il ruolo delle Camere di Commercio che sono la casa delle imprese. È indiscutibile – ha aggiunto – che abbiamo vissuto tre anni sulle montagne russe. Poi, all’improvviso, abbiamo avuto degli esiti positivi insperati. I dati parlano del passato, ma ci devono aiutare per fare analisi predittive sul futuro. L’allarmismo dello scorso anno era anche comprensibile, ma abbiamo saputo tutelarci e il quadro economico si è rasserenato». In tema di geopolitica, Prete ha evidenziato che «prima il mondo era tutto disponibile. Adesso ci siamo resi conto che effettivamente ci sono aree più favorevoli e aree disagevoli. Si è creato un meccanismo di riallocazione delle imprese, ma anche di affidabilità dei mercati».
L’esordio dei “Dialoghi” si è concentrato sul tema caldo del momento, la guerra in Ucraina, analizzandone le conseguenze geopolitiche, i rischi di escalation, il ruolo di Usa e Cina, ma anche del ruolo dell’Italia e in particolare del Nordest in questo scenario. A parlarne, moderati da Silvia Boccardi, giornalista Will Media e Sky Tg24, sono stati Arduino Paniccia (Presidente di Asce Scuola di Competizione Economica Internazionale), Orietta Moscatelli (Askanews; Limes) e Gilles Gressani (Direttore, Le Grand Continent; SciencesPo).
«Siamo passati – ha detto Gressani – da una tripartizione in consumatori, flussi e orizzontalità a quella di oggi: dove prima c’erano consumatori oggi ci sono cittadini da armare contro un nemico, dove c’erano flussi oggi ci sono stock da riempire perché non ci siano carenze. Il mondo orizzontale, infine, non è più credibile ma va ridefinito un quadro di alleanze. Siamo in fase molto ambigua ed enigmatica, in un interregno di incertezza in cui dobbiamo riuscire a ridefinire equilibri. Dobbiamo uscire da questa passività che ci porta a subire i cambiamenti e andare verso una mentalità che ci renda protagonisti e fautori di questi cambiamenti». «Dobbiamo definire – ha aggiunto Paniccia – qual è il ruolo della nostra area in questa situazione: siamo un’area importante ma non abbastanza rappresentata e non abbastanza presente».

E il ruolo dell’Europa e del Mediterraneo sono stati poi approfonditi anche panel successivo, con Federico Rampini, Antonio Zanardi Landi (Ambasciatore dell’Ordine di Malta presso la Santa Sede; già Ambasciatore d’Italia in Russia) e Paolo Petiziol (Presidente, Associazione Mitteleuropa). «Abbiamo un sistema industriale eccezionale – ha detto Zanardi Landi -. Rimane il problema della sicurezza, che non è risolto. Sono stato alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e ne sono uscito preoccupato. Si è parlato di come adattare il sistema europeo alla guerra e non di politica estera. A mio parere, un po’ di pessimismo c’è, perché una Russia instabile e pesantemente sconfitta è un rischio per tutti a livello internazionale.
Oggi possiamo far tutto tranne che mostrare diversità di visioni, ma dobbiamo già cominciare a riflettere su come affrontare la situazione quando questa guerra sarà finita». Zanardi Landi ha anche parlato del ruolo della Polonia, ribadito anche da Rampini. «Varsavia – ha detto – aveva capito subito quanto reale fosse il rischio dell’invasione dell’Ucraina paventato dagli Stati Uniti. Esiste un asse Washington-Varsavia». Quanto al Mediterraneo, «sembra in ebollizione – ha detto -, con rischi e opportunità molto grandi». La questione Mediterranea, per Rampini, è nuovamente una questione energetica importante.
Gli ultimi due panel della prima giornata di Open Dialogues a Udine si sono concentrati su reshoring, friendshoring e reshuffling e sulla possibilità di un capitalismo a zero emissioni.
Il Fvg può avvantaggiarsi dal rientro “in casa” di produzioni che la globalizzazione aveva portato a delocalizzare nei Paesi emergenti? Possiamo cioè diventare destinazione dei processi di reshoring o friend-shoring? Federico Rampini ha lanciato questa opportunità e questa sfida. l punti di domanda sono necessari. Siamo disposti ad assumerci i maggiori costi? I nostri giovani vorranno lavorare ancora nella produzione di beni che avevamo demandato all’estero? E siamo disposti, soprattutto, a portare a casa i costi ambientali di molte produzioni che abbiamo “scaricato” lontano da noi, sui altri Paesi? Rampini ne ha parlato nel panel dedicato allo “stato di salute” della globalizzazione, temi di cui il giornalista, con la moderatrice Silvia Boccardi, ha dibattuto con Carlo Altomonte (Professore Associato di Economics, Università Bocconi) e Carmine Porello (Responsabile Delegazione di New York, Banca d’Italia).

Porello ha ripercorso le tappe della globalizzazione, impetuosa crescita internazionale in prevalente attitudine e apertura al libero scambio. «La globalizzazione – ha spiegato – ha sollevato dalla povertà centinaia migliaia e migliaia di persone di Paesi in via di sviluppo, e si è accompagnata a un processo di moderazione dei prezzi e di rarefazione dei conflitti, dagli anni ’80, per un trentennio, fino alla grande crisi finanziaria del 2008. Crisi che ha cominciato a contrastare questa apertura al libero scambio».
Si è dunque cominciato a parlare di rallentamento della globalizzazione e sono emerse restrizioni agli scambi di beni, servizi, capitali e persone. «Negli ultimi anni, specie dopo la crisi Covid-19 e poi la guerra in Ucraina, le imprese nelle loro comunicazioni al mercato hanno cominciato a parlare di reshoring e friendsoring. Se questo fenomeno prende ulteriormente piede, sui concetti di redditività, profitto, benessere, prosperità, anche se sono accadute non senza distorsioni, si andranno a ritagliare un ruolo concetti come sicurezza, affidabilità delle forniture, ridondanza delle stesse. Questo può avere un impatto significativo sulla dinamica dei prezzi». La globalizzazione, dunque, se pure ha avuto delle distorsioni, per il delegato Banca d’Italia, è stata un volano di crescita e benessere straordinario «e a mio avviso sarebbe opportuno discutere di come migliorarla – ha evidenziato – piuttosto che privarci di uno strumento così potente». Attenzione dunque a dare per morta la globalizzazione, «anche perché – ha concluso – con una frammentazione e un isolamento delle economie, il Fondo Monetario Internazionale, pur come indicazione di massima, ha stimato che i costi potrebbero raggiungere il 7% del prodotto globale, praticamente la somma del prodotto di Germania e Giappone».
Dove sta guardando l’Europa e dove dovrebbe guardare, ha chiesto a Rampini la Boccardi. Perché non al Friuli Venezia Giulia, ha risposto il giornalista. «Nel momento in cui la globalizzazione, almeno così come l’avevamo conosciuta negli ultimi 30, entra in crisi, le alternative sono tante – ha detto – e perciò anche noi dobbiamo essere competitivi sul mercato come possibile destinazione di queste ri-localizzazioni».

Rampini ha evidenziato ciò che sta avvenendo negli Stati Uniti, specie a seguito dell’Inflation Reduction Act e il Chips Act, da un lato per fare in modo, in pratica, che l’economia a zero emissioni non sia completo appannaggio della Cina e dall’altro per riportare l’industria di semiconduttori su suolo americano. «Ciò si sta verificando e che di fatto si stanno ricostruendo in Usa fabbriche di semiconduttori in molti Stati. Ma tutto questo ci deve far riflettere sulle conseguenze». E si è tornati alle domande. Innanzitutto, siamo disposti a pagare la differenza di prezzo e l’aumento dei costi che produrre “in casa” comporta? Dobbiamo essere consapevoli peraltro che 30 anni di globalizzazione non si spazzano via in poco tempo, 30 anni in cui la Cina è riuscita anche ad affermarsi per la sua affidabilità sui prodotti, le infrastrutture e il controllo di qualità. Diversificare su altri Paesi emergenti, come India, Vietnam, Messico, non è un processo automatico. L’India, per esempio, non ha la classe operaia della Cina, né le infrastrutture. Si candida a essere alternativa alla Cina, ma ci vuole tempo.
Il Fvg si può dunque candidare? Sì, ma deve farsi le domande fondamentali. Oltre a quello dei costi, per Rampini c’è da chiederci se i giovani, oggi e in futuro, «vorranno ancora produrre cose? Avere una carriera nel manifatturiero? O preferiscono andare a lavorare da Google?». Poi il tema fondamentale: «vogliamo recuperare produzioni purché non siano sporche. Vogliamo solo lavori puliti, vogliamo girare in Tesla ignorando che cosa serve per produrla, vogliamo ignorare quanto viene sporcato il pianeta per produrre un’auto elettrica: non ci interessa purché sia lontano da noi. Questo è un problema grosso: se vogliamo riportare a casa dobbiamo chiarirci le idee su quello che vogliamo e non vogliamo prendere in carico».
Un punto di vista diagonale è arrivato da Altomonte, che ha parlato di reshuffling più che di reshoring. «ֿLa Cina – ha detto – con la crisi finanziaria non ha smesso con la globalizzazione, ma ha investito proporzionalmente di più per investimenti interni. Questo potrebbe un po’ falsare la nostra percezione che la globalizzazione mondiale stia davvero rallentando». Ha poi parlato di intensità dei flussi di commercio, che possono variare molto velocemente, variazioni che possono permetterci di acquisire nuove quote di mercato. «I dati ci dicono che l’Europa, dalla crisi finanziaria in poi, ha cominciato ad accrescere il valore aggiunto all’interno e a diminuire l’investimento sul resto del mondo. Si sta dunque radicando molto di più l’interno e sta esportando meno valore aggiunto all’esterno. Ciò significa opportunità che si aprono all’interno del mercato europeo».
La prima giornata ha sviluppato ulteriormente questi concetti con l’ultimo panel, che si è concentrato sulle possibilità di andare verso un business a zero emissioni, tra costi, ambientali, sociali, culturali, ma anche necessità e opportunità per la transizione dell’economia del futuro. Si sono approfonditi la revisione dei principi chiave del capitalismo per renderlo più compatibile con esigenze ambientali e sociali nuove, la lotta a fenomeni come il “green washing” e il ruolo della finanza Esg in questo ambito; e la Cop, ossia i meccanismi di compensazione per i danni causati dai cambiamenti climatici, con una nuova frattura tra Occidente e Sud del mondo. Sono intervenuti Silvia Merler (Direttrice ESG e Policy Research, Algebris Investments), Ana Nacvalovaite (Research Fellow presso il Kellogg College, Università di Oxford) e Lorenzo Fioramonti (Direttore, Institute for Sustainability, Università del Surrey; già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).

Con l’introduzione del presidente della Regione Massimiliano Fedriga si è aperta la seconda giornata, quella conclusiva, di Open Dialogues for Future. L’innovazione nell’economia e nel lavoro – e come adattare il business ai cambiamenti così rapidi e radicali che le nuove tecnologie stanno portando alla società – sono stati i temi trattati dal primo panel di esperti della mattina. Con il direttore scientifico di Odff Federico Rampini, hanno approfondito il tema David Gram (Co-Fondatore di Diplomatic Rebels; già Direttore per l’Innovazione, LEGO), Carl Benedikt Frey (Oxford Martin Citi Fellow e Direttore del programma Future of Work, Università di Oxford) e Paola Pisano (Docente di Gestione dell’Innovazione, Università di Torino; già Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione).
A introdurli, con un videomessaggio inviato appositamente per Open Dialogues, un vero guru tech come Kai-Fu Lee, ceo di Sinovation Ventures ed ex ceo di Google China. «Innovazioni come il quantum computing e l’intelligenza artificiale sono solo alcune delle grandi rivoluzioni che si stanno stratificando tutte insieme in questi anni – ha detto -. A esse le persone guardano insieme con entusiasmo e paura». Kai-Fu Lee ha parlato di realtà non replicabili per lo sviluppo tecnologico come la Silicon Valley e la China, ma ha anche sottolineato le potenzialità dell’Europa e dell’Italia. «In una situazione internazionale in cui c’è la percezione che Usa e Cina siano i leader del cambiamento, perché hanno saputo “cavalcare” la rivoluzione tecnologica rapidissima in atto, l’Italia deve essere consapevole dell’ottima formazione universitaria che offre e che è punto nodale della crescita». Per Kai-Fu Lee è infatti essenziale investire nella formazione universitaria soprattutto in materie come l’ingegneria e la ricerca collegata a questo comparto. Un comparto che però deve essere finanziato di più: bisogna creare un ambiente favorevole per attrarre fondi che investano su questo ecosistema. «L’Italia – ha ribadito – è un grande Paese, con grandi talenti, grandi intelligenze, grandi università e ricercatori. È importante che pensi “globalmente” e non solo guardando al suo interno, finanziando la formazione ingegneristica e scientifica, la ricerca e aumentando il finanziamento alle startup».
Temi su cui si è innestato anche il docente di Oxford Carl Frey, che ha evidenziato storica diversificazione della produzione italiana e il valore delle Università come attrattori e produttori di talenti: elementi che secondo il docente sono la chiave per sfruttare lo sviluppo tecnologico come volano per la crescita economica. «Bisogna però essere anche capaci di costruire nuovi tipi di imprese – ha ammonito Frey – da affiancare alle produzioni storiche. Bisogna costruire un ambiente in grado di attrarre talenti, bisogna che il sistema di tassazione sia favorevole allo sviluppo d’impresa e al lavoro, per fare in modo che il business possa scalare velocemente», come dal recente passato sta accadendo negli Stati Uniti, i quali si avvantaggiano anche di un grande mercato interno integrato per i servizi, che l’Europa dovrebbe perseguire a sua volta quanto prima.
David Gram, dalla sua esperienza in Lego, ha poi introdotto una nuova figura di imprenditore, del presente e del futuro: bisogna infatti parlare oggi di una cultura di “intra”preneurship, una capacità di creare impresa integrata e pronta a gestire un momento in cui la radicalità è la nuova normalità. «Il successo futuro – ha detto l’imprenditore – dipende dalla capacità di sperimentare e muoversi velocemente sul mercato. Perché questo è così difficile per le grandi imprese? Purtroppo, quando cresciamo, sia come esseri umani sia come imprese, smettiamo di sperimentare. La paura di fallire e non essere perfetti ci fa restare fermi. I bambini sperimentano continuamente, passano attraverso migliaia di errori e imparano. Bisogna sempre riprovare e migliorare la tecnica: la stessa cosa deve valere per l’azienda. Possiamo certamente creare delle “cornici” di sicurezza entro cui sperimentare con più fiducia perché quando dimentichiamo di sperimentare, diventiamo rigidi e fermi».
I passi chiave da fare per costruire questa “intrapreneurial culture”, per Gram, sono la capacità di essere focalizzati e con una chiara visione del risultato che con l’innovazione vogliamo raggiungere. Secondo: essere organizzati per essere agili – perché non si fa innovazione nello stesso modo in cui si fanno le cose tradizionali: bisogna diventare ambidestri, con una mano continuare a gestire al meglio l’esistente e con l’altra sperimentare il nuovo. Inoltre, sviluppare nel team innovatore la cultura dell’essere imprenditore e infine essere un “ecosistema”, non muoversi cioè in modo isolato, ma al contrario creare partnership con altre imprese e con startup. Nel futuro dobbiamo dunque essere dei “ribelli diplomatici”, perché l’innovazione incontra sempre tantissima resistenza.
«Rischi, se sei un innovatore, che la resistenza ti faccia abbassare la testa e conformarti o ti faccia abbandonare. I millennial però non vogliono più lavorare in realtà così». È necessario porre in essere cinque modalità di lavoro. Primo, essere consapevoli che «ci sarà sempre qualcuno che odierà il vostro progetto di innovazione: dovrete accettarlo – ha suggerito –. Inoltre, dovrete rompere solo con le regole dell’impresa che siete in grado di capire, avendo rispetto per come ha operato finora». Terzo: saper costruire “una tribù”, un gruppo, un gruppo di persone e talenti che siano felici di seguire. Quarto: «scrivere lettere d’amore» all’organizzazione, essere umili e invitare le persone esterne al team a “entrare”, coinvolgerle. «Infine: far “brillare” le persone. I vostri colleghi e chi lavorerà con voi sarà sempre felice di collaborare», ha concluso. Solo così il nuovo imprenditore potrà equilibrare lo spirito del ribelle con le skill del diplomatico.














E proprio sulla diplomazia l’ex ministro all’innovazione e consulente per l’innovazione dell’ex ministero degli esteri Paola Pisano ha sperimentato un grande progetto di intelligenza artificiale, la “predictive diplomacy”, ossia la diplomazia predittiva. «Come consulente del ministero degli esteri – ha spiegato –, abbiamo lavorato su più fronti: portare un po’ di innovazioni ed essere un po’ “radicali” all’interno dei ministeri, portare le competenze sulla gestione dell’innovazione ai diplomatici, dunque la formazione, e fare in modo che il ministero fosse più presente internazionalmente su tematiche quali tecnologia e innovazione. Su queste basi, abbiamo sviluppato un percorso che sfrutta le nuove tecnologie per aiutare i diplomatici a fare il loro lavoro: utilizzare cioè i sistemi di intelligenza artificiale per analizzare grandi quantitativi di dati e riuscire a dare informazioni utili affinché possano prendere decisioni migliori».

La sessione successiva, alle 11.30, è cominciata con l’introduzione del presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini. I temi discussi nel panel precedente sono calati nella realtà economica regionale con alcuni dei maggiori protagonisti dell’economia Fvg: Gianpietro Benedetti (Presidente e AD, Danieli), Zeno D’Agostino (Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale), Paolo Fantoni (Presidente, Fantoni) e Riccardo Illy (Presidente di Polo del Gusto, Gruppo Illy).
Per la sessione pomeridiana, Open Dialogues si sposta dalla Sala Valduga nell’attigua Chiesa di San Francesco. È un “side event” speciale, dedicato ai giovani, alle sfide e alle opportunità che il mondo d’oggi – e soprattutto di domani – presenta loro. Ne discutono Luciano Monti (Docente di Politiche dell’Unione europea, LUISS Guido Carli; Coordinatore Scientifico, Fondazione Bruno Visentini), Cecilia Sala (Giornalista, Il Foglio; vincitrice del premio “Penna d’Oro”), Francesca Bardelli Nonino (Responsabile comunicazione web, Nonino Distillatori) e Federica Tremolada (Managing Director Southern and Eastern Europe, Spotify).
Alle 16.15 è il momento di trarre le conclusioni dell’intensa due-giorni. Per chiudere i lavori, interviene il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e quindi le riflessioni finali sono portate dal presidente Giovanni Da Pozzo e dal direttore scientifico di Odff Rampini.
C’è un muro sempre più alto che i giovani devono superare per entrare a tutti gli effetti nell’età adulta e “responsabile”. Per uscire, cioè, dalla famiglia, trovare un lavoro e formare una famiglia a loro volta. E questa altezza è stata anche quantificata, in modo simbolico: nel 2006 il muro era alto 1 metro, nel 2011 1 metro e 32, oggi 1 metro e 41. Sempre più difficile da superare e sempre più alto se il giovane è anche una donna, di più ancora se una donna del Sud. A trasformare in questa metafora molto immediata una serie di indicatori economici e dati statistici è stato Luciano Monti, docente di politiche dell’Ue alla Luiss Guido Carli e Coordinatore Scientifico della Fondazione Bruno Visentini, intervenuto in apertura del panel conclusivo della due-giorni dei Open. Ultimo panel che si è spostato dalla Sala Valduga nella Chiesa di San Francesco, per un side event speciale dedicato ai giovani, che infatti hanno partecipato numerosissimi. Con Monti, hanno portato le loro esperienze sul palco anche Cecilia Sala (giornalista de Il Foglio e vincitrice del premio “Penna d’Oro”) e Federica Tremolada (Managing Director Southern and Eastern Europe, Spotify) e Francesca Bardelli Nonino, responsabile comunicazione web della Nonino Distillatori.
«I giovani – ha aggiunto ancora Monti – non possono sognare se non vedono al di là del muro e ciò porta molti di loro a lasciare il Paese. Solo uno su tre vuole lavorare nella sua città. Uno su quattro vuole lasciare l’Europa o comunque l’Italia. La sorprendente notizia che hanno dato ai nostri sondaggi è che il 50% vuole lavorare in futuro come Partita Iva e lavoratore autonomo, il 15 % come imprenditore e il resto come dipendente». Essere protagonisti e responsabili, dunque, delle proprie passioni e del proprio lavoro, come ha raccontato Cecilia Sala, che è partita costruendo attraverso i social la sua professionalità di giornalista di esteri, mettendosi in gioco, viaggiando e raccontando con la competenza che la rende oggi una delle voci giornalistiche più giovani e autorevoli in materia e una delle “podcaster” più ascoltate su Spotify. Spotify che è anche la “casa” di Federica Tremolada, di cui è managing director per il Sud ed Est Europa, e che è riuscita a unire gli studi in economia alla passione per la musica, lavorando sempre nel campo dell’innovazione e delle tecnologie. E di «innovazione come semplificazione» ha parlato anche l’ospite friulana del panel, Francesca Bardelli Nonino, impegnata a «trovare i valori cuore dell’azienda per comunicarli con i tempi veloci di oggi. E soprattutto con il piacere e il divertimento di raccontare. Credo – ha evidenziato – che la genuina passione faccia la differenza. Non esistono prodotti vecchi, ma solo narrazioni noiose. Io ho voluto coinvolgere le persone che ci seguono nella quotidianità della vita aziendale e rompere la distanza tra l’azienda e il pubblico».

«Siamo partiti come edizione zero, ma in conclusione possiamo affermare di essere stati una prima edizione a tutti gli effetti, con tutti gli eventi sold out e un grande seguito anche delle dirette streaming che ci hanno permesso di raggiungere con le nostre riflessioni centinaia di altre persone ancora. Possiamo già annunciare che Udine continuerà anche il prossimo anno a portare in città e in Friuli il cuore del dibattito sui grandi temi geopolitici e geoeconomici internazionali». La conferma è arrivata direttamente dal presidente della Cciaa Pn-Ud Giovanni Da Pozzo negli interventi di chiusura di Open Dialogues for Future.
Alla conferma di Da Pozzo si è unita la soddisfazione per gli esiti della’evento da parte di Rampini. «Abbiamo toccato tanti temi, partendo dalla più calda attualità come la guerra in Ucraina e le conseguenze sulla nostra economia, sul nostro ruolo e quello dell’Europa, per poi addentrarci in temi come il reshoring, il friend-shoring e il re-shuffling, di cui anche l’Italia e il Friuli Venezia Giulia possono diventare destinazione e gestirne sfide e opportunità. Abbiamo parlato di un’economia che vuole andare verso le “emissioni zero” e di come adattare il business al cambiamento così repentino di questi anni a livello globale. E anche di come già lo stanno adattando alcune fra le maggiori realtà economiche del Fvg, con i capi di Danieli, Fantoni, Illy e del porto di Trieste. Lungo tutto questo percorso, ci siamo sempre rivolti con il pensiero al futuro e ai giovani, che il futuro rappresentano e che sono stati i protagonisti dell’evento conclusivo, tanto tra il pubblico quanto nel panel finale, che mi fa davvero piacere sottolineare: un panel che porta l’America a Udine e Udine in America. Un panel “americano” nel senso che un dibattito così è di quelli che si possono vedere in America. Un panel che parla di “cultura del fare”, un panel dominato da giovani donne, imprenditrici di sé stesse, che hanno deciso di progettare e costruire la loro carriera professionale. La loro presenza è un modello e che ci consente un momento di autostima per il nostro Paese, in cui abbiamo una presidente del consiglio donna e una capa dell’opposizione donna. Tutto questo in tanti altri Paesi non è concepibile, è un risultato ancora lontano».